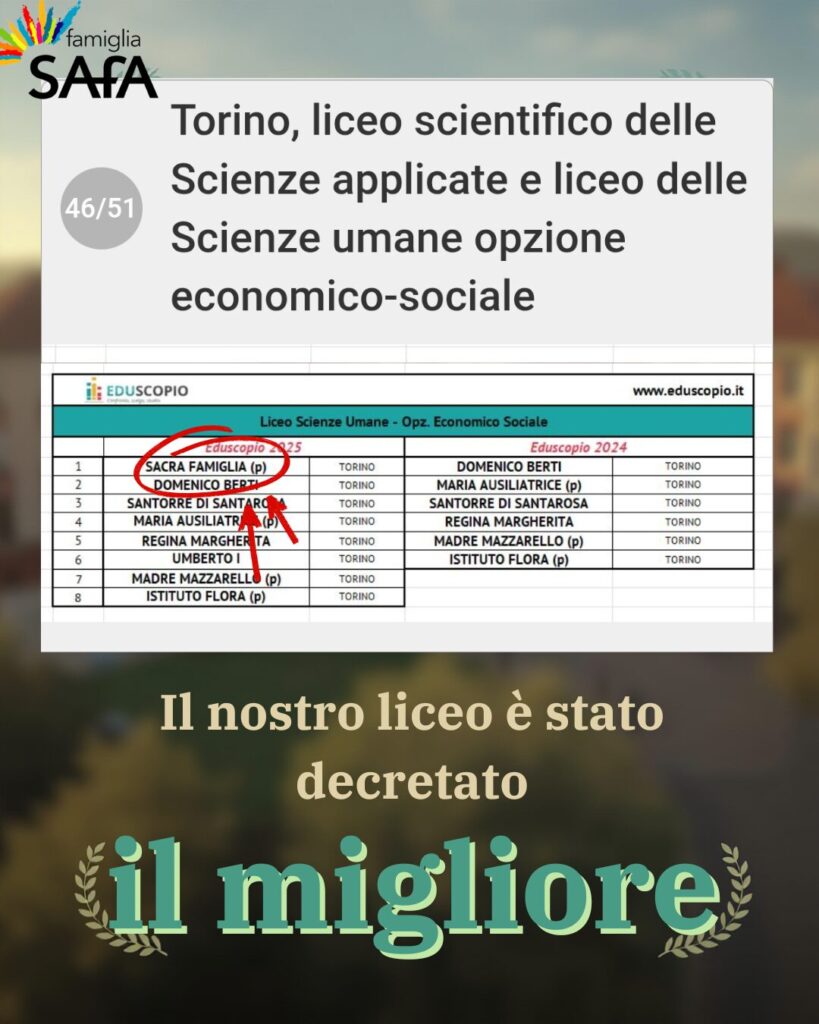Eleonora aveva 17 anni, ma sembrava più grande. Non per come si vestiva o parlava, ma per come camminava nel mondo: a testa alta, con la schiena dritta e lo sguardo deciso. Solo quando si sedeva, tendeva a curvare la schiena per lenire un po’ il dolore che la tormentava da quando era piccola.
Aveva i capelli corti e sbarazzini, nerissimi come il carbone, che le cadevano sugli occhi verdi smeraldo. Aveva la carnagione così chiara che le labbra carnose sembravano più rosse del normale. Giurava a tutti che d’estate prendeva il sole, e lo faceva veramente. Solo che si scottava subito e, dopo aver patito le pene dell’inferno, tornava bianca come prima. Nessuna via di mezzo.
Era alta un metro e settantacinque, con spalle strette, braccia lunghe e sottili. Aveva un modo di correre un po’ goffo, perché muoveva le braccia in maniera scoordinata rispetto al resto del corpo, come un polipo. Questa sua caratteristica faceva tanto ridere da trasmettere sicurezza alla gente che non la conosceva.
Eleonora teneva molto all’impressione che dava agli altri, voleva sempre mostrarsi disponibile per chi aveva bisogno e con la sua sicurezza faceva sì che chiunque si potesse fidare di lei.
Era sicura, sì, tranne quando si parlava del suo passato e del segno indelebile che portava sul costato. Una cicatrice liscia, ancor più chiara del suo incarnato. La copriva sempre con molta cura, indossando magliette larghe o canottiere morbide, pantaloni baggy, sempre streetwear, sempre comoda, sempre pronta a mimetizzarsi senza sembrare mai fragile.
Lavorava all’ufficio postale del suo paesino: era l’unica lì, e tutti dicevano che era troppo giovane per un lavoro così serio. Nessuno però si sarebbe mai permesso di rinfacciarglielo. Eleonora era tosta. Parlava poco, ma quando parlava, le parole pesavano. Credeva vivamente in quello che diceva. E lo diceva con forza.
Quel giorno caldo di aprile, tra la solita pila di lettere e bollette, trovò una busta diversa.
Era indirizzata a lei. Nessuno le scriveva mai.
Il mittente era sconosciuto. La carta, ruvida e sottile, tremava un po’ tra le sue dita. Si guardò attorno e si sedette alla scrivania.
Infilò un dito al lato della busta per togliere la colla, senza strappare tutto. Tirò fuori un foglietto di carta, sopra poche righe scritte a mano:
“So cosa ti è successo. Non sei sola. Anche io ho una cicatrice. Ci sono verità che non restano sepolte per sempre.”
Il cuore di Eleonora batteva forte. Per un attimo pensò che qualcuno volesse farle del male, ma le parole non sembravano una minaccia. Sembravano… vere. Empatiche.
Passò la giornata distratta, tornando mille volte con la mente a quella lettera. Chi l’aveva scritta? Come faceva a sapere?
Quella notte non dormì. Il giorno dopo, un’altra lettera. Era breve, ma conteneva una rivelazione:
”Mi chiamo Livia. Ho 19 anni. So cosa hai vissuto perché ci sono passata anch’io. Non ti conosco, ma ho riconosciuto il modo in cui ti tocchi il fianco quando pensi che nessuno ti guardi. È lo stesso che ho io. Ti ho vista l’estate scorsa, al lago, quando la tua maglietta si è sollevata un secondo e tu ti sei subito coperta. Non era solo imbarazzo. Era paura. E io quella paura la conosco. Se vuoi parlare, ti aspetto domani, sulla panchina dietro la chiesa. Al tramonto. Non sei sola.”
Eleonora leggeva e rileggeva la lettera. Quella scena al lago… sì, la ricordava. Una giornata calda, la sabbia che si infilava tra le dita dei piedi, qualche ragazzo che scherzava, un tuffo improvviso e, per coprire i capelli dagli schizzi, la maglietta si era sollevata troppo. Non pensava che qualcuno potesse aver notato. E invece qualcuno aveva visto. Qualcuno che sapeva leggere i segni.
Non era un caso. Non era curiosità. Era una chiamata silenziosa tra chi ha sofferto e chi ha imparato a riconoscere la sofferenza negli altri.
Una fitta la colpì. Il dolore le prese la pancia e la gola. Stropicciò la lettera e la lasciò cadere a terra.
Qualcuno era come lei. Avevano vissuto le stesse cose. Sperava che fosse tutto uno scherzo. Stava male al pensiero dell’accaduto di undici anni prima.
Il dolore si fece più forte e sentì mancare il respiro. Si accasciò a terra. Non riusciva più a controllarsi. Iniziò a piangere e il respiro veniva sempre meno. Si mise a contare fino a 20 per calmarsi. Era un metodo che aveva imparato da piccola, quando stava chiusa nell’armadio mentre suo padre urlava contro sua madre.
Si sentì male e in colpa. Si era promessa che non avrebbe più sofferto a causa di quel mostro.
Rimase a terra per qualche minuto, forse una mezz’ora, aveva perso la concezione del tempo.
Con le guance bagnate e gli occhi rossi si alzò da terra, o meglio ci provò, la testa improvvisamente le iniziò a girare vorticosamente. Per un momento vide tutto nero e decise che la soluzione era di sedersi di nuovo a terra e non ostentare con i movimenti.
Volse lo sguardo alla sua sinistra e vide la lettera accartocciata. Per la rabbia la strappò definitivamente. Erano passati troppi anni. Lei non aveva niente a che fare con quella ragazza. Non avevano niente in comune. Quella “Livia” non sapeva niente di lei. Era solo una stalker che l’aveva seguita al lago mentre era con i suoi amici.
Lei non sapeva niente della sua sofferenza.
Il giorno dopo andò al lavoro come routine. Aveva gli occhi scavati per la notte difficile. Era stanca e aveva deciso che la sera non sarebbe andata all’appuntamento. Controllava l’orologio ogni mezz’ora. Non vedeva l’ora che finisse la giornata per staccare e andare a casa. Voleva riposare. Si continuava ad immaginare la pizza della signora Luisa, la più buona di tutto il paese e dintorni. Vista la sera passata durante la quale non aveva toccato cibo e il panino poco invitante che aveva preparato la mattina stessa per il pranzo, aveva deciso che avrebbe potuto concedersi una serata sgarro e ordinare una pizza d’asporto.
Suonate le 18, riordinò gli ultimi fascicoli e smistò le lettere arrivate nel pomeriggio. Tirò un sospiro di sollievo quando fece l’ultimo giro di chiave, era finalmente libera e poteva andare a mangiare. Abitava a pochi minuti dall’ufficio postale. La luce del sole rifletteva sulle finestre dei negozi presenti nella via. Era fine aprile e ormai non faceva più freddo, anzi la brezza serale era piacevole.
Eleonora stava camminando in direzione opposta alla chiesa, le sue gambe lunghe e snelle si stavano muovendo da sole, mentre lei con la testa pensava ancora alla lettera del giorno prima. Odiava questa “Livia” anche se non la conosceva. Le aveva fatto ripensare ad un periodo della sua vita che aveva cercato di eliminare per sempre dalla sua testa. Ma forse non era colpa della stalker, non era colpa di quella ragazza se il suo passato era stato quello e se lei non l’aveva ancora affrontato.
Per tutti quegli anni, aveva tenuto nascosta la sua infanzia a chiunque le si avvicinasse. In seconda superiore non era riuscita ad andare al ballo con quel ragazzo che tanto le piaceva per la paura. Non era più riuscita in nessun modo a stare in costume o indossare magliette corte davanti a qualcuno.
Ma il problema non si presentava solo con gli altri: anche quando faceva scorrere l’acqua della doccia per farla diventare calda, aspettava a spogliarsi e non era per una questione di freddo ma perché non riusciva a vedersi nuda. Si ripeteva sempre che non fosse colpa sua, ma non ci credeva fino in fondo.
Eleonora si fermò istantaneamente, come se avesse visto un morto: non riusciva più a vedersi nuda. Il pensiero la spiazzò.
Lei, che da piccola amava stare al mare e prendere il sole.
Lei, che da ragazzina amava indossare i vestitini corti estivi.
Lei che non ha mai avuto paura di niente, negli ultimi anni è diventata un’altra persona tanto da non riuscire a vedersi nuda.
Forse lo sapeva in fondo. Lo sapeva, ma non l’aveva mai pensato così chiaramente.
In fondo “Livia” non era così terribile come aveva pensato fino a quel momento. Forse poteva essere la soluzione al tormento che la perseguitava. Parlarne con qualcuno l’avrebbe fatta stare meglio.
Si svegliò improvvisamente dai suoi pensieri e si trovò davanti alla chiesa. Quando era che i suoi piedi avevano iniziato a camminare da soli e l’avevano portata dalla parte opposta di casa sua? Aveva deciso che non avrebbe incontrato nessuno, e quell’idea continuava a rimanere. Ma il corpo la stava portando dietro la chiesa. Anche se il suo cuore desiderava altro, non riusciva a fermare le gambe. Si stavano muovendo da sole, finché non si trovò dietro una panchina.
Una donna le dava la schiena.
Trascinata da chissà quale forza si avvicinò, senza dire niente. Livia si girò di scatto, spaventata dalla presenza silenziosa. Quando si rese conto che era Eleonora, le sue guance si colorarono di rosso e fece un piccolo sorriso. Sì alzò di scatto e allungò la mano verso di lei per presentarsi, ma vedendo la diffidenza della coetanea, si risedette e aspettò un momento prima di parlare.
Eleonora la squadrava da testa a piedi: aveva dei bei capelli scuri e lunghi, occhi profondi come la notte e lentiggini sparse per tutto il viso. Lo sguardo acceso faceva capire che era una ragazza sveglia. Si concentrò sulla mezza gonna marrone che portava e la camicetta bianca di lino che lasciava scoperte le braccia. Una borsetta piccolina era lì a fianco.
Non sembrava una persona di cui poter avere paura.
Livia le fece cenno di sedersi ed Eleonora lo fece, ma mantenendo le distanze. Lo spazio tra di loro era simbolo di paura e perplessità.
La ragazza dai capelli lunghi decise che era meglio non parlare, ma, da persona molto diretta che era, si alzò la maglia quel tanto che bastava per mostrare la cicatrice sulla pancia.
Eleonora sentì il respiro mancarle.
Gli sguardi si incrociarono e due vite tanto diverse si intrecciarono. Solo con gli occhi le ragazze si erano capite. Non c’era bisogno di parlare. Sì erano già dette tutto.
Per Eleonora fu troppo e scoppiò a piangere. Il segreto, la pressione e l’ansia di non farlo sapere a nessuno, la vergogna che aveva addosso per il suo passato. Tutto si sfogò in quel pianto con una persona sconosciuta che aveva tanto da ascoltare e condividere.
Non era più sola. Poteva parlarne con qualcuno, qualcuno che l’avrebbe capita.
Dopo essersi asciugata le lacrime iniziò a parlare a bassa voce:
”Avevo sei anni,” disse. “Mio padre… di notte. Diceva che era un gioco tra noi. Mi diceva di non fare rumore. Non dimenticherò mai la prima volta. Eravamo tornati da una cena, era molto tardi e mi ero addormentata in macchina. Arrivati a casa mio padre mi prese in braccio e mi portò in camera mia. Mia madre era molto stanca, come me d’altronde, e andò subito nella sua stanza per prepararsi a dormire. Mio padre dopo avermi lasciata sul letto se ne andò. Ero già addormentata quando lui rientrò.”
Fece una pausa e guardò Livia, cercando di decifrare la sua espressione. Si preoccupò, perché le sembrava che avesse uno sguardo di disprezzo e decise di non continuare. Ma Livia la incitò di andare avanti, che la stava ascoltando e voleva sentire la sua storia.
Eleonora si fece coraggio e continuò:
”Stavo già dormendo ma mi svegliai perchè non sentivo più le coperte addosso. Ricordo ancora il brivido che mi pervase il corpo a causa dello spiffero della finestra. Ma non era solo il freddo, era la presenza in camera mia che mi mise paura.”
Le scese una lacrima, ma non si fermò.
”Una volta… quando ho cercato di scappare, mi ha spinta contro un mobile. È così che mi sono fatta la cicatrice.”
Abbassò lo sguardo, le mani che stringevano il bordo della panchina tremavano. Erano rosse per la forza impressa. “Ho detto a tutti che ero caduta. E da allora, ho imparato a stare zitta. Quando se n’è andato, anni dopo, ho pensato che fosse finita. Ma non lo è mai, davvero.”
Livia le prese la mano.
”Anche il mio patrigno. Per anni. E io… anche io ho avuto paura. Di non essere creduta, di rovinare tutto. Di sentirmi sbagliata.”
Le due ragazze si liberarono di un peso portato per anni. Erano in due finalmente, non erano più da sole.
Suonate le 21, Eleonora invitò Livia a mangiare quella famosa pizza della nonna Luisa. Parlarono tanto e scoprirono di avere molte cose in comune, come la passione per le lunghe camminate in montagna.
Finita la cena si salutarono. Eleonora e Livia erano cambiate e ne erano consapevoli.
Il rientro a casa fu silenzioso per tutte e due.
Quel silenzio pieno di pensieri fu il primo passo verso qualcosa di nuovo.
Qualche settimana dopo, il paese si svegliò con un cartello affisso fuori dall’ufficio postale:
“Se hai una cicatrice che nascondi, non devi farlo più da sola.
Parlare è forza, non vergogna.
Chi ti ha fatto male deve risponderne.
Noi siamo qui. E ti crediamo.”
C’era un numero. E un nome: “Iniziativa Eleonora & Livia”. Uno sportello d’ascolto, uno spazio sicuro, incontri settimanali.
La prima riunione pubblica si tenne nel salone del municipio. Eleonora si guardò allo specchio prima di uscire. Per la prima volta dopo anni indossava qualcosa di elegante: un abito lungo color avorio, semplice ma bellissimo, con una spallina sottile che lasciava scoperto un lato del costato.
La cicatrice si vedeva chiaramente.
Non l’aveva coperta. Non l’aveva nascosta sotto i vestiti. Era lì, nuda e fiera, era parte di lei. Non più un segreto. Non più una vergogna.
Quando salì sul palco, il silenzio fu pieno di attenzione. Alcuni la guardarono stupiti. Ma nessuno giudicò. E anche se l’avessero fatto, non avrebbe avuto più importanza.
”La verità si porta addosso, a volte anche sulla pelle” disse al microfono, con voce ferma. “Io non mi nascondo più. E se anche solo una di voi, oggi, si sente meno sola… allora questa cicatrice è diventata bellezza.”
Gli applausi arrivarono prima lenti, poi forti.
Eleonora sentì una vampata di calore per tutto il corpo. Aveva le guance rosse e finalmente sentì di essere una voce. Una presenza. Un faro per chi viveva ancora nel buio.
Carlotta Rivera, III LES